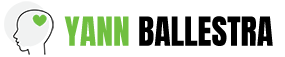Conferenza tenuta a Bordighera, Chiesa Anglicana il 26.09.2015
“Se c’é qualcosa che desideriamo cambiare nel bambino, dovremmo prima esaminarlo bene e vedere se non è qualcosa che faremmo meglio a cambiare in noi stessi” C.G.Jung
Sono un analista ad orientamento junghiano e mi occupo di terapie espressive attraverso l’utilizzo della Sand Play Therapy, della psicoterapia attraverso il cavallo e dell’arteterapia.
In questa presentazione si cercherà di dare un senso alle manifestazioni del disagio psichico contemporaneo: in particolare a tutte quelle forme, sintomi e sindromi, classificate in altrettante nuove classi patologiche e che hanno posto il problema di nuove cure, nuove ricerche, nuove risorse, soprattutto a causa di problemi di adattamento dei bambini al sistema scuola, ma anche alla gestione dei bambini all’interno del nucleo famigliare.
Come terapeuti, in questo contesto (famigliare e scolastico), siamo sollecitati nel dare delle indicazioni e degli strumenti pratici per intervenire e modificare un funzionamento interpretato come non ordinario, non gestibile, addirittura patologico, in particolare nell’ambito della prima infanzia fino all’adolescenza.
Da diversi anni lavoriamo (come gruppo di psicologi e educatori) attraverso l’associazione, sia accogliendo le richieste direttamente dalle famiglie, sia collaborando con le organizzazioni e le istituzioni del nostro territorio, ad esempio una bella collaborazione è nata con l’agenzia della famiglia di Vallecrosia e le scuole. Abbiamo messo in piedi progetti con lo scopo di rispondere alla presa in carico di bimbi con sospetto o diagnosi precoce di disturbi dell’apprendimento (DSA), disturbi da deficit dell’attenzione, iperattività, disturbo evolutivi del comportamento e dell’autocontrollo (ADHD). I progetti attivati sono due: “Mani in Pasta” e “Cavallino Bianco”. (descriverli)
I bambini integrati in questi progetti sono stati inviati direttamente dalle maestre dopo un primo screening o semplicemente delle osservazioni, senza una vera e propria diagnosi,anche perché mediamente hanno 5-6 anni. Una parte di loro è stata descritta come bimbi incontenibili, generalmente considerati ingestibili se non all’alto prezzo di condizionare l’intera classe, con grandi difficoltà di adattamento al sistema scolastico.
Ad esempio: Un bambino da noi seguito (inquadrato sospetto ADHD) era descritto dalle maestre come aperto, curioso, simpatico e sorridente, ma per le richieste da lui formulate (quando usciamo? andiamo in giardino?, andiamo nell’orto? (risorse per altro disponibili in quella scuola) e per i suoi tempi e le modalità di esprimersi attraverso il corpo sembrava proprio che la scuola lo “imprigionasse” (sono le parole delle maestre), dicevano: ha buone capacità di comprensione, ma enormi difficoltà nel mantenere la concentrazione. Quello che è emerso durante l’osservazione clinica nel tempo e spazio dei progetti attraverso le attività espressive è stato invece un bambino motivato, rispettoso delle regole, con una buona psicomotricità e una capacità di concentrazione e presenza all’attività che soddisfava il 100% del tempo, ossia due ore. La nostra domanda spontanea è stata: “perchè ce lo hanno mandato?” “questo bimbo non ha nessun problema”. In realtà a scuola era realmente ingestibile. Cosa è cambiato allora? E’ cambiato l’ambiente, lo spazio e i ritmi proposti, ma soprattuto il tipo di sguardo posto su quello specifico individuo.
La nostra risposta, come terapeuti, non va nel senso di un adattamento dell’individuo all’ambiente, soprattutto là dove l’ambiente, la società, possiamo dire, ha rinunciato al riconoscimento della complessità delle manifestazioni individuali, all’unicità dell’individuo. Il mondo in cui viviamo sembra manifestare una tendenza pericolosissima alla rimozione dei bisogni fondamentali del bambino e ma dell’essere umano in generale: in che modo? prima di tutto non lo si osserva, non lo si ascolta, non si cerca di capire chi è. La scuola, le associazioni che propongono le attività extra scolastiche, gli spazi istituzionali all’interno dei quali ci muoviamo tutti, sono sempre orientate ad un risultato prestabilito, ad un livello standardizzato di performance, mai alla curiosità di confrontarsi con un modo di esserci nel mondo all’interno di uno spazio e di regole condivise. Ciò che interessa è la standardizzazione, il risultato, l’applicazione e l’adattamento ad un protocollo.
Per questo motivo quello che è cambiato nell’accompagnamento di questo bimbo è stato prima di tutto il fatto di offrirgli uno spazio libero e protetto all’interno del quale presentarsi e manifestarsi, nel rispetto comunque di regole condivise e nell’incontro con altre specificità, altri bambini: un ambiente psichicamente nutriente e confortevole. Noi lo abbiamo osservato attentamente e di conseguenza abbiamo cercato di rispondere ai suoi bisogni (identificati in: contatto umano, a volte proprio fisico come dare la mano, altre volte nella ricerca dello sguardo, e infine la richiesta di abbassarsi alla sua altezza), per altri bambini dello stesso gruppo invece i bisogni di base erano altri (il contatto e la presenza non potevano passare dal corpo, la modalità doveva essere più indiretta, perché la sofferenza già più importante aveva portato a strutturare una reticenza e un insieme di difese più complesse) . Altri bisogni di questo bimbo erano la curiosità rispetto all’esplorazione dell’ambiente (i cavalli, il bosco, il ruscello), e gli abbiamo proposto (a lui e così come all’intero gruppo) delle attività che dall’esplorazione libera portassero i bambini, progressivamente ad investire sempre più un centro condiviso di concentrazione e equilibrio attraverso l’uso degli oggetti che si trovavano (sculture di pietre, di rami), progressivamente l’inclusione in spazi definiti costruiti insieme nel bosco con elementi naturali (tronchi) e momenti di condivisione in gruppo dell’esperienza, stando anche fermi e seduti. Li abbiamo quindi osservati, abbiamo individuato i loro bisogni e abbiamo cercato di soddisfarli rispettando le dinamiche del gruppo. Il tutto cercando di invitarli ad una presenza consapevole di ciò che li circondava, prima di tutto l’ascolto attraverso i propri strumenti percettivi (vista, olfatto, tatto, udito), e a come tutto ciò risuonava nel loro interno e cosa sollecitava a livello immaginativo. Il nostro obbiettivo è sempre quello di portare il bambino a capire come sta qui, in questo momento e, se si porta dietro un disagio o un sentimento negativo da esperienze precedenti, come spesso accade, aiutarlo ad esprimerle e trasformarle, scioglierle, grazie a questo nuovo modo di stare insieme in un ambiente dove non c’è giudizio né interpretazione, ma accoglienza e proposte di espressione di sé.
C’è un meccanismo molto utile della psiche che è l’immaginazione. Nel momento in cui la realtà non soddisfa la possibilità del nostro essere unici di manifestarsi cominciamo ad attingere dal bacino dell’immaginazione che è molto ricco e, a livello energetico anche potente. Successivamente le immagini cercano un aggancio alla realtà per concretizzarsi e ciò permette alla persona di incarnarsi, essere presente nel mondo attivando un dialogo con la realtà e gli altri esseri umani in una dinamica creativa. Se ciò non accade l’immaginazione diventa delirio. Le fantasie sono delle spinte energetiche che la realtà deve raccogliere come risorse. Se la realtà le respinge continuamente perché crede di avere già tutte le immagini precostituite da offrire agli individui e in particolare i bambini, proponendo surrogati dell’immaginazione attraverso la TV o videogiochi, o nei momenti formativi e espressivi delle indicazioni predefinite come il modo di disegnare (le case si disegnano così, bisogna colorare nei margini..), e impedendo alla specificità del singolo di concretizzarsi portandolo a rimanere agganciato ad immagini che non avranno più nulla di creativo e che innesteranno dei bisogni non autentici e non vitali. Potete immaginare cosa accade nella psiche: uno dei rischi maggiori è l’alienazione da sé con la sofferenza conseguente. Un altro grosso problema è il conflitto tra adattamento e individuazione. Se mi sforzo ad adattarmi mi sento “imprigionato” come diceva il bambino, se provo ad esprimere me stesso non ho spazio, trovo solo vuoto, non sono riconosciuto.
Il nostro intervento è orientato al riconoscimento dei loro bisogni, della loro specificità attraverso l’integrazione del loro disagio e dei sintomi che manifestano, all’interno di situazioni il più possibili naturali che riequilibrano le energie, le rimettono in circolo attraverso modalità condivisibili utilizzando anche suggestioni immaginative, attraverso la narrazione di storie che sollecitano diversi tipi di proiezioni e identificazioni e non ultima l’espressione corporea. Il tutto all’interno di una relazione protetta e mai giudicante. Per fare questo le attività espressive ( musicoterapia, arteterapia, ecc e l’utilizzo degli animali come il cavallo) sono strumenti molto utili e potenti.
Tuttavia l’integrazione si fa sempre più ardua. I sentieri già tracciati, come modelli di sviluppo, che vengono proposte ai bambini, le strade e gli spazi dove iniziare il proprio percorso utilizzando mappe di orientamento, non sono più piste delle chiare orientate verso un definito orizzonte, ma piuttosto labirinti oscuri senza centro, dove è molto facile perdersi. abbiamo da un lato un’iper rigidità e dall’altra una mancanza di sostegno. Vengono formulate richieste sempre più difficili, ma non si forniscono gli strumenti. I cosiddetti paletti educativi, gli argini tanto necessari e rassicuranti per una psiche in formazione sono stati abbandonati. Il risultato è la mancanza di contenitori saldi poiché l’attuale interpretazione della realtà è che non ci sia nulla da contenere, come se i bambini fossero involucri vuoti. Il bambino, il paziente, il portatore del disagio diventa un malato da curare, a causa di un meccanismo proiettivo che noi analisti conosciamo bene. Uno sguardo sistemico ci ricorderebbe che quel bambino non è altro che il paziente designato, colui che esprime la sofferenza per tutti noi, colui che ancora, attraverso la sua ribellione, i suoi sintomi, prova a chiedere aiuto e a portare una tensione verso la vita e l’autorganizzazione che non trova riconoscimento.
In questo contesto gli strumenti da noi utilizzati nel riconoscere e offrire nuovi contenitori adatti a contenere processi evolutivi e trasformativi, così come abbiamo già ampliamento descritto sono tutti riconducibili alle terapie espressive.
In generale possiamo cominciare col dire che una terapia espressiva è tutto ciò che, all’interno di un contesto psicoterapeutico, non utilizza come canale comunicativo primario la dimensione intellettivo-verbale.
L’aspetto fondante il senso e lo scopo delle terapie espressive è racchiuso nel loro nome, due sono infatti le colonne imprescindibili di questi dispositivi: da una parte l’aspetto terapeutico e dall’altro l’aspetto espressivo.
L’aspetto terapeutico è ciò che collega chi soffre al gruppo umano di appartenenza attraverso un sistema di cure o di prendersi cura, in funzione di ripristinare uno stato di salute.
La parola salute viene dal latino salus che ha la stessa radice di salvo, l’origine è sanscrita (tutto, intero) e greca (olos, intero, indiviso, illeso).
Per gli antichi essere in salute voleva dire essere integri, non danneggiati. In effetti, in ogni cultura l’ideale della salute è quello dell’equilibrio e della totalità tra la persona e se stessa, ma anche tra la persona e il suo ambiente.
Quando questa condizione viene a mancare, a causa di una molteplice varietà di fattori, molti dei quali come abbiamo visto legati all’ambiente, ma prima che insorga la malattia, ovvero la condizione patologica, abbiamo la crisi, che definisce, idealmente, il passaggio più o meno lungo tra due stati di equilibrio. In questo senso la crisi apre anche ad una possibilità.
E’ importante sottolineare cosa si intende per salute-stato di crisi-possibilità-patologia, perché è in questo schema che possiamo inquadrare ciò che succede ai nostri ragazzi oggi.
Se una persona, un bambino o un ragazzo è in uno stato di salute perturbato, percepisce se stesso come diviso, separato da, non integro, non integrato al sistema umano di appartenenza, innanzitutto perché non potrà fare le cose come gli altri, non riuscirà a partecipare all’ordinario modo espressivo dei suoi simili. La domanda che sorge è: “Perché questo individuo non è sano e quindi integro-integrato?” E’ nato con una differenza? Una mancanza? Di sicuro c’è qualcosa che gli impedisce di conformarsi: perché a scuola seduto non ci sta, perché sembra non avere capacità attentive, memoria, perché manifesta una forte paura, ansia, addirittura angoscia, o, ma ne è sovente la conseguenza, aggressività, è violento. E di cosa ha paura? Cos’è che lo spaventa?
Partiamo dal concetto che ogni individuo è una manifestazione unica e irripetibile della vita, che non esiste un solo modo corretto e condivisibile di stare al mondo, una sola intelligenza ottimale valutabile e classificabile, ma una pluralità di modalità espressive dell’umano che concorrono, nelle loro unicità, appunto, a determinare un sistema culturale complesso e condivisibile, all’interno del quale ogni individualità può entrare in relazione, cooperare e manifestare se stesso nel naturale processo individuativo.
Ma per quale motivo questo non avviene? Sempre più spesso, nella nostra epoca, il sistema di appartenenza all’interno del quale l’individuo è iscritto, gli impedisce di manifestare la propria specificità poiché si applicano schemi rappresentativi dell’umano troppo rigidi, unilaterali. Addirittura, ma è ormai riconosciuto, il sistema, la società, si trova lei stessa in uno stato di tale crisi perdurante che ha generato un vuoto all’interno di se stessa e non più possibilità, è, in analogia con una malattia fisica, lo stato cronico, dove non c’è più speranza e ci si abitua a stare così, nel nostro caso in un vuoto che non ha sostanza, che non offre spazio e non sostiene il singolo processo individuativo dell’individuo.
In questo senso la persona prova, tenta di rispondere a questa mancanza innanzitutto non accettando, ribellandosi e quindi creando caos (ecco il senso a volte dell’iperattività, agitazione, ribellione, violenza). Soprattutto se bambino non molla e si ribella, prima di provare a conformarsi al vuoto. Non accetta e grida il suo rifiuto attraverso la produzione di comportamenti, sintomi che dovrebbero produrre un effetto di messa in questione del sistema, che invece proietta immediatamente il patologico su chi sta semplicemente tirando un grosso, enorme, campanello d’allarme.
Ciò che viene definito ormai da tempo come la “crisi dell’occidente” è in corso dagli anni 1980 attraverso uno stato di dispersione e di caos. l’inquietudine è tanta e si manifesta sia socialmente sia individualmente sotto forma di angoscia e sofferenza.
Di fronte alle nuove sofferenze la “medicina” reagisce ignorando i grandi cambiamenti antropologici della nostra epoca tra cui il più importante è sicuramente l’ibridazione della cultura e del vivente con la tecnologia. Tutto ciò che siamo, esprimiamo, desideriamo… i nostri vissuti e sentimenti, passano e vengono comunicati sempre più attraverso supporti tecnologici. Il nostro lavoro(educativo, pedagogico, psicoterapeutico), per far fronte a questo modello non può essere una serie di metodi per disciplinare e normalizzare i nostri pazienti in funzione di un adattamento.
Le nuove (manifestazioni) della sofferenza, dall’infanzia, all’adolescenza e l’età adulta si esprimono tendenzialmente attraverso l’annullamento dell’immaginazione e l’imprigionamento dell’energia in coazioni legate alle dipendenze: da psicofarmaci, alcool, droghe, videogiochi, social network, giochi d’azzardo online, smartphone. L’aspetto centrale del malessere espresso dalle persone riguarda il senso di solitudine in senso profondo, ossia non il fatto di vivere da soli o di stare da soli (il che non implica necessariamente una separazione) ma di non aver più dei legami profondi a ciò che fonda, sostanzia culturalmente l’umano. Questo porta le persone a cercare continuamente dei legami fuori da sè, in internet ad esempio, e per i bambini nei giochi elettronici e nella TV, senza rendersi conto che il legame che ci accomuna va cercato dentro di sé. Questa solitudine deriva dunque dall’incapacità a essere in relazione. Questa solitudine (separazione da sé) genera l’artefatto della personalità(che non ha nulla a che vedere con l’aspetto artistico) è la dimensione all’interno della quale la sofferenza prende corpo a causa della rimozione della complessità del vivente, della sua cultura e che ha come effetto l’allontanamento del vivente da se stesso, un vero e proprio esilio da se stessi e genera, nei bambini, quello che gli psicologi infantili descrivono come falso Sé.
Se la modernità aveva esiliato l’uomo dalla Natura, la postmodernità (ossia la nostra epoca, quella della tecnologia) lo ha esiliato da se stresso, pretendendo di semplificare la complessità del funzionamento umano in un artefatto standardizzato senza una matrice culturale specifica (cioè senza un comune denominatore sociale radicato nella storia, nelle credenze e nei rituali di accompagnamento allo sviluppo) e infine senza dei bisogni individuali soggettivi..
Il senso di solitudine si manifesta quando avviene una rottura nel contatto profondo con noi stessi e la nostra matrice culturale. In questi casi una persona si sentirà sola anche se ha molti rapporti. Mentre invece, un artigiano che lavora la maggior parte del tempo solo, così come un musicista o uno scrittore, potranno essere si dei solitari ma al tempo stesso con profondi legami e affetti soddisfacenti, capaci di nutrire il loro essere attraverso il legame profondo con le proprie fondamenta psichiche. Con l’ossessione di risolvere la solitudine, o la sensazione di essere diversi e incompresi in questo mondo, molti umani cercano di colmare il vuoto senza porsi il problema della separazione, del fatto che sono obiettivamente separati da sé e da ciò che potrebbe unirli al resto della comunità di appartenenza e oltre. La ricerca di contatti e relazioni li lascia invece sempre più spesso nella situazione di una “separazione condivisa”, Insieme e separati.
La solitudine è quindi un’altra causa importante delle nuove sofferenze psichiche, è una solitudine come incapacità a sentirsi in relazione e viene avvertita già dai bambini. Induce l’impotenza, l’impossibilità ad agire, ad essere toccati affettivamente dal mondo ad accettare il contagio psichico, l’”infezione”: cioè l’affetto, il contatto, le emozioni, che è poi l’unica via per riuscire a manifestare se stessi nel mondo trasformando il nostro agire in atti creativi (questo è proprio lo scopo delle terapie espressive: ripristinare questo canale ricucendo la separazione, attraverso la musica, l’arte, la natura)
Per cercare di capire il senso della sofferenza attuale bisogna anche intendere il diktat che la nostra società esprime: “Sii il meno possibile te stesso, non essere come sei… per divenire il più possibile gelatina modellabile”. E questo modello è tanto più difficile da realizzare per chi già non è come dovrebbe o non è ancora definitivamente strutturato, per questo motivo la trappola si chiude proprio su di loro, i bambini, attraverso la medicalizzazione e la patologizzazione della sofferenza (non stai bene perché sei malato, tu hai qualcosa che non va, perché non riesci ad adattarti… dovrei adattarmi a questa solitudine?). La testimonianza più evidente è rappresentata come abbiamo detto dai casi di bambini detti “iperattivi” o secondo i nuovi modelli nosografici ADHD. Bambini che invece, attraverso la nostra personale esperienza, quando lasciati liberi di manifestare la loro specificità, in particolare in contesti naturali o attraverso terapie espressive, risolvono, sciolgono quasi magicamente la serie di sintomi per i quali sono stati definiti e imprigionati in categorie diagnostiche. Il riduzionismo psichiatrico e psicologico in questo senso invece ha creduto di aver trovato la causa dell’iperattività e dei disturbi dell’attenzione in generale, in un deficit nella produzione della dopamina: una concezione drasticamente semplicistica e lineare del problema. Una volta posta l’etichetta si è pensato di sapere tutto sul bambino e la sua specificità dietro l’etichetta.
Attraverso le esperienze condotte con bambini di questo genere, osservati all’interno di differenti modalità terapeutiche espressive si è constatato quanto la manifestazione del disagio possa essere plastico. Se un bambino avesse un deficit nella produzione o nell’equilibrio dei livelli di neurotrasmettitori produrrebbe i sintomi sempre e non solo in determinati contesti ambientali. Noi ci siamo in particolare concentrati sul ripristinare una relazione interna, prima di tutto con se stessi, quindi focalizzando l’interesse non sui sintomi, sui comportamenti bizzarri, ma sul bisogno di ridurre la separazione prima descritta tra sé e gli stati profondi che fondano l’essere umano e la sua psiche, anche attraverso la sua manifestazione somatica, corporea, il suo stare fisicamente nello spazio e con gli altri. E al tempo stesso dando importanza alle basi culturali di appartenenza sulle quali ogni individuo ha bisogno di essere radicato, secondo il modello etnopsichiatrico. Così ci si è trovati spesso in imbarazzo in riunioni istituzionali tra genitori, insegnanti, neuropsichiatri e psicoterapeuti in un contesto artificioso ma purtuttavia necessario, all’interno del quale l’immagine del bambino che emergeva non era assolutamente condivisibile, come nel caso che abbiamo descritto prima.
La mancanza di tempo all’interno delle famiglie, di spazi di reale condivisione affettiva, di solitudine e artefattualizzazione della relazione, cioè dove l’incontro non avviene sulla base dei sentimenti e bisogni, ma sulla rimozione di questi bisogni e sentimenti e sulla rimozione della complessità del nuovo essere umano in cerca di basi, sponde, limiti per poter porre se stesso e dargli forma. Si è lasciato che ad accogliere i bisogni più profondi ci pensassero modelli sempre più artefatti e devianti, come alcuni giochi elettronici profondamente traumatizzanti (come GTA) o l’accesso incondizionato al web, che destrutturano profondamente o piuttosto sospendono l’individuo bambino su un vuoto esistenziale profondamente angosciante e traumatizzante, lo pongono difronte ad un terrore panico per il quale la sola reazione istintuale e sana non può essere se non la fuga, espressa in una continua agitazione e incapacità a stare in una realtà che si presenta come apocalittica.
Per spiegarvi meglio questo concetto abbiamo un esempio. Sempre all’interno del nostro gruppo terapeutico nel progetto “cavallino bianco”, avevamo alcuni bambini che manifestavano una grossa sofferenza: sempre 6 anni, descritti come agitatissimi, incontenibili, incapaci di condividere momenti con gli altri, a casa come a scuola distruggevano sempre tutto, nei loro dialoghi, anche con noi, si esprimevano spesso con frasi del tipo: “la vita è una merda, non vedo l’ora di morire”, oppure “bastardo uccidiamolo” rivolti ad altri membri del gruppo, refrattari a qualsiasi tipo di contenimento verbale o fisico. Mettevano continuamente in scena non giochi di fantasia ma uno specifico videogioco che riatualizzavano, GTA. Indagando abbiamo saputo che solo di fronte alla TV o ai videogiochi stavano calmi, quindi ecco la medicina trovata….Ma la cosa stupefacente è che nel momento in cui abbiamo questionato i genitori, questi erano inconsapevoli del contenuto di quel videogioco. Già lasciare solo un bimbo di fronte a un videogioco per ore, fosse pure Mario Bros aliena e uccide la fantasia, separa da se stessi, come abbiamo visto. Ma lasciare un bimbo di 6 anni ore difronte a GTA lo porta inevitabilmente a subire un abuso e un trauma, che devierà per certo la sua personalità in formazione. Questo però accade continuamente, il nostro esempio non è un’eccezione.
La scuola e le insegnanti, pressate da richieste di performance e standardizzazione del gruppo, non lasciano spazio e non offrono alternative espressive alle differenze creative che caratterizzano gli esseri umani. i bambini in questione esprimono poi sintomi che sono grida disperate di aiuto, non sono malati. E invece vengono associati a un deviante sociale, colui che non soddisfa la norma. In realtà questi bambini sono gli ultimi avvertimenti di quelle istanze umane più profonde e autentiche in cerca di una soluzione e al tempo stesso l’ultima possibilità di accogliere la consapevolezza di quanto la nostra realtà stia alienando l’umano dall’umano e dalle sue più autentiche risorse espressive e creative.
E modalità ce ne sono veramente molte, ad esempio la poesia.
Chandra Livia Candiani scrive:
«Il silenzio mi passava tra le vene/ sembra infinito il silenzio». Sono le parole di un poeta. Ma ha nove anni e forse nemmeno frequenta più la scuola. Si chiama Marius, è un bambino rom. Ha imparato a comporre versi nella sua scuola, quando ha incontrato una strana maestra, diversa da tutte le altre, venuta per condurre un seminario di poesia. Di cosa si tratta? Risponde Alice, otto anni, italiana: «Tranquillità/ silenzio/ concentrazione/ un po’ di pazzia/ piacere di ascoltare/ il nostro amico silenzio».
Questa maestra sa seminare bene e coltivare il bene: si chiama Chandra Livia Candiani, vive a Milano, dove è nata, ma ha origini russe. Scrive una poesia tra le più significative oggi in Italia (il suo prossimo libro uscirà a febbraio per Einaudi) e da sette anni conduce seminari di poesia in diverse scuole elementari a tempo pieno della sua città. Nell’ultimo periodo s i è concentrata sulla periferia nord-ovest, tra via Console Marcello e viale Espinasse. Le classi interessate erano dapprima le quarte e le quinte; poi solo le quinte, in seguito ai tagli all’istruzione.
I bambini sono italiani e immigrati: dalla Cina al Perù, dall’Ucraina alla Siria; chi è appena arrivato, chi è in Italia da tempo, chi è nato e cresciuto qui. Molti hanno storie di grande sofferenza e fatica. In prima linea stavano i rom. «Stavano», perché «sono scomparsi dalla scuola dopo l’ultimo sgombero — racconta Candiani, lasciando intuire l’entità della perdita —. Le loro poesie esprimevano tutta la ricchezza e la differenza di una cultura compatta, articolata e complessa».
Leggere le poesie di questi bambini è un’esperienza straordinaria. All’inizio si stenta a crederci, eppure nulla di ciò che hanno scritto è stato corretto né modificato. A loro sono stati affidati due strumenti prima di ogni cosa: libertà e fiducia. Ma in che modo è nato l’incontro tra questa «grande schiva poetessa» — come l’ha definita una volta Vivian Lamarque — e i bambini? «Una maestra — ricorda Candiani—voleva un poeta a scuola e lo chiese a una sua vecchia insegnante di liceo che fece il mio nome. Andai a scuola e, non sapendo che di solito i poeti vanno a parlare delle loro poesie e a farsi fare domande sull’arte di poetare, feci scrivere i bambini. Così, un po’ a tentoni. Alla maestra piacque, ma soprattutto i bambini chiesero poesia e poesia, e insomma ritornai, e a poco a poco mi inventai un piccolo metodo. Quella prima volta una bambina cinese scrisse un tema che diceva: “Credevo che le poetesse fossero noiosissime, invece questa aveva una vocina piccola piccola e quando ho visto le sue scarpe ho visto che portava forse il 32, quindi è una principessa”. Quando lo lessi tremai, perché avevo brutte scarpe vecchie, ma lei vedendole piccole mi scambiò per una principessa. Un’altra volta arrivai in una classe dove una maestra stava sgridando i bambini. Provai a parlare ma non mi sentiva, allora mi feci piccola piccola e stavo lì in piedi timidissima; un bambino minuscolissimo si alzò dall’ultima fila di banchi e quatto quatto mi avvicinò e mi disse: “Volevo dirti che tu hai una voce bellissima…”, poi ritornò al banco».
Il suo metodo lo racconta solo ai bambini. A tutti gli altri racconta la postura, l’atteggiamento che adotta: «Ho cercato un metodo che non emarginasse chi parla altre lingue. Partiamo da un punto in cui conoscere molte parole non è affatto quello che conta. Partiamo dal corpo, dalla presenza e dagli stimoli sensoriali che la vita regala a ogni istante. Non inizio mai spiegando loro cos’è la poesia, ma segnando un leggero e variabile percorso per andare insieme in cerca del luogo in cui abitano le parole».
Dopo aver trovato la consapevolezza del corpo e dello spazio che lo contiene, si comincia a lavorare su alcuni temi, ad esempio «I grandi», «Il mondo», «L’addio». Spesso si inizia con «Il silenzio». Candiani: «I bambini conoscono per lo più il silenzio teso, il comando a cui si obbedisce facendosi piccoli, raggrinzendosi. E invece cerco di trasmettere a loro un silenzio che allarga, il piacere del silenzio che è ascolto di sé, del mondo, dell’altro, della sinfonia di cui facciamo parte. È con meraviglia che scoprono il mondo che il silenzio rivela. E alla fine dico: ora vi do un compito che dura tutta la vita. E loro abbassano le orecchie;ma quando affermo: “ascoltare il silenzio, farci tana, aspettare lì le parole”, ridono».
Ma dove sono le parole? Per scoprirlo è necessario porsi delle domande. «Tante domande — spiega Candiani —. Non importa a chi. Tanto meno rispondere, ma far risuonare le domande e mettersi in ascolto. Forse qualcuno o qualcosa risponderà, forse la domanda si scioglierà nell’aria, forse risuonerà dentro, forse farà ridere, forse piangere. È la voglia di comunicare che fa trovare le parole. Ma anche lo scarto, sentire che la poesia è anche musica e magia, che si possono fare dei salti con le parole e farli fare agli altri. Si può far sorridere o tremare. E soprattutto si può non sapere».
Tanta umiltà, nessuna pretesa di formare dei poeti, ma l’intenzione di regalare degli strumenti. «Strumenti che non ci abbandonino quando la vita è dura e non sappiamo come o a chi dirlo, strumenti che non ci lascino soli quando la gioia ci sommerge e vorremmo lasciare tracce, dire a qualcuno che si può essere felici. Strumenti per conoscere noi stessi, quando ci siamo persi, per tenerci stretti quando ci sentiamo abbandonati, per innamorarci di questo sconosciuto che ci sta sempre accanto, che siamo noi».